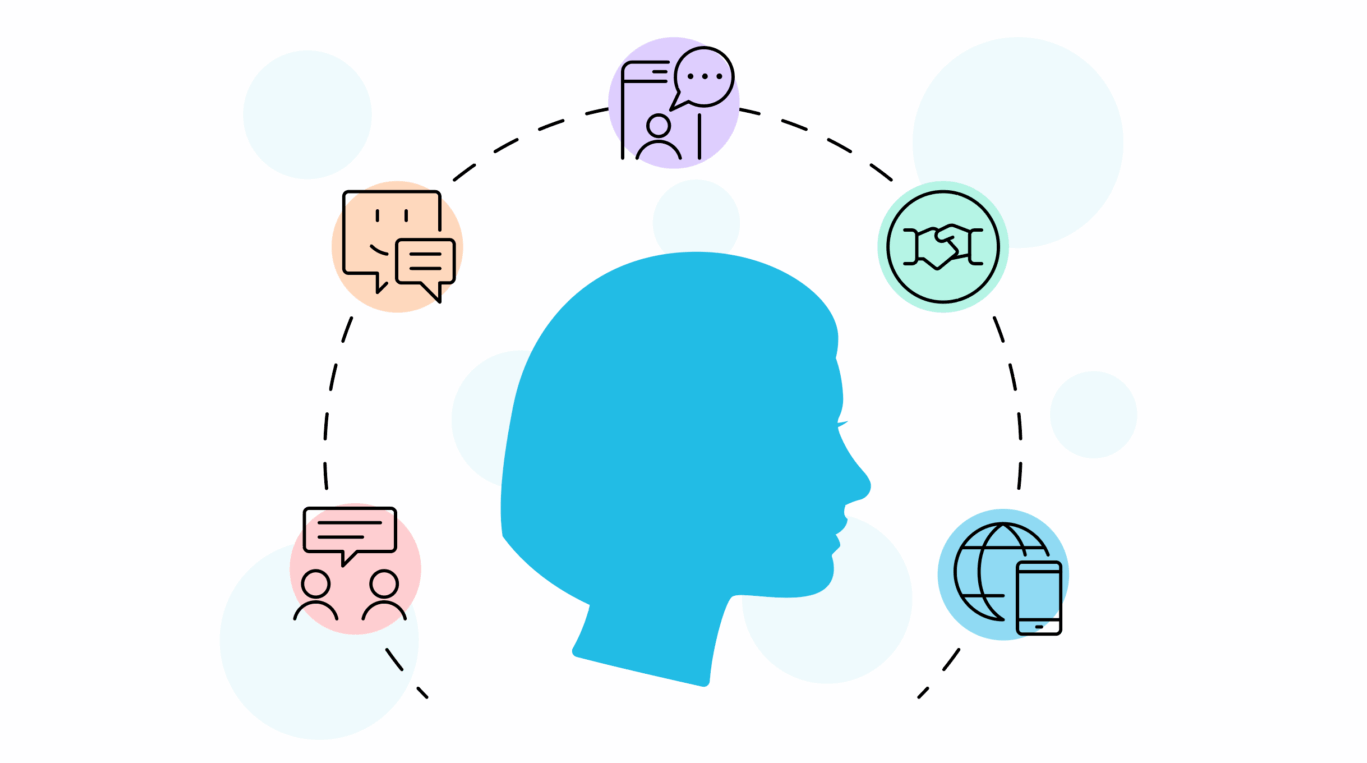Venticinque anni fa, Don Nutbeam, uno tra i massimi esperti di health literacy a livello mondiale, elabora un modello teorico dell’alfabetizzazione alla salute, ancora oggi riconosciuto come punto di riferimento per chi si occupa della materia. Il modello descrive l’alfabetizzazione alla salute come un apprendimento progressivo e uno sviluppo di competenze classificate in tre livelli: alfabetizzazione alla salute funzionale, interattiva e critica.
Sul numero di agosto di Health Promotion International, Nutbeam pubblica un articolo per fare il punto, 25 anni dopo la teorizzazione del suo modello, sugli sviluppi e lo stato dell’arte dell’health literacy in termini di definizioni teoriche e ricadute nella pratica.
Gli ultimi 25 anni hanno visto una crescita fenomenale dell’interesse accademico, politico e operativo per l’alfabetizzazione alla salute. Tale interesse è facilmente osservabile nell’aumento del volume di articoli scientifici sull’health literacy, ma è riscontrabile anche nelle politiche governative e nella crescita dell’offerta formativa per gli operatori di salute pubblica.
Hanno avuto origine e sono proliferati nuovi concetti e definizioni di alfabetizzazione alla salute e ampliati i suoi ambiti di applicazione. Le idee, le innovazioni e i dibattiti scaturiti da questo straordinario periodo di interesse sul tema, hanno notevolmente arricchito la comprensione del contributo che una migliore alfabetizzazione alla salute può apportare alla salute personale e pubblica e alla lotta alle disuguaglianze.
Nonostante questi progressi, però, ci si trova oggi, in una fase che presenta anche alcuni rischi.
Il primo rischio è che il concetto e la definizione di health literacy siano diventati così diffusi e onnicomprensivi da rischiare di perdere di significato. Non solo esistono numerose definizioni di health literacy ma anche una gamma crescente di sottocategorie, che riflettono ad esempio diversi contesti (ospedali e scuole health literate), malattie (alfabetizzazione sul cancro, alfabetizzazione sulla salute mentale, ecc.), media (alfabetizzazione alla salute digitale, mHealth) e temi di promozione della salute (alfabetizzazione alimentare, alfabetizzazione sull’alcol). Sebbene sia importante riconoscere che la maggior parte di queste variazioni ha una sua legittimità, lo scopo fondamentale del concetto di health literacy – ovvero sostenere lo sviluppo di conoscenze e competenze a beneficio degli individui, delle comunità e della società in generale – può andare perso a causa della confusione di idee, teorie, modelli e conseguenti dibattiti accademici. Il rischio, in sostanza, è che l’health literacy possa diventare una panacea teorica per tutti i problemi di salute pubblica, ma una soluzione pratica per nessuno.
Se ciascuno di noi intende qualcosa di diverso quando usa il termine “alfabetizzazione alla salute”, diventa sempre più difficile trovare una base comune per la ricerca scientifica e la difesa pubblica dell’health literacy. Trovare un quadro di riferimento comune è molto difficile. Ognuno ha le proprie preferenze concettuali e un interesse personale e professionale nell’utilizzare determinate definizioni e orientamenti.
Per fare chiarezza è necessario ricordare che l’alfabetizzazione alla salute ha le sue radici nel concetto generale di alfabetizzazione, ovvero costituisce un insieme osservabile di competenze personali (e sociali) che consentono agli individui di trovare, comprendere e utilizzare le informazioni per prendere decisioni in materia di salute e agire in una serie di circostanze nella loro vita quotidiana. Le competenze di alfabetizzazione alla salute si basano sulle competenze sviluppate nel corso della vita di alfabetizzazione nella lettura, nella scrittura e nella matematica e, a livello del singolo, possono essere osservate, misurate e classificate in modo oggettivo.
Le competenze di health literacy sono inoltre trasferibili (applicabili e adattabili ai cambiamenti di contesto) e necessariamente mutevoli lungo il corso della vita. È importante sottolineare che, come nel caso delle competenze di base nella lettura e nel calcolo, queste competenze possono mutare ed essere sviluppate attraverso l’esposizione a diversi stimoli ambientali, in particolare attraverso contesti abilitanti.
In secondo luogo, è fondamentale ricordare che la capacità individuale di utilizzare le proprie competenze è sempre determinata dal contesto in cui tali competenze si agiscono. Riconoscere e comprendere la complessità dell’impatto dei contesti politici, culturali e sociali sull’health literacy aiuta a mantenere alta l’attenzione su interventi che lavorino alla creazione di ambienti più favorevoli, abilitanti, equi, in particolare per coloro che possiedono limitate e scarse competenze di alfabetizzazione alla salute.
Il secondo rischio emerso negli ultimi 25 anni di studi sull’ health literacy ha a che fare con la multi interpretazione del concetto (e quindi la sua conseguente dispersione) e il derivante dibattito accademico che ha fatto sì, che ad oggi, ci sia una sproporzione evidente tra l’impegno teorico sul tema (articoli, dibattiti, modelli e teorie) e l’interesse delle Istituzioni pubbliche nell’investire nello sviluppo di politiche e interventi volti a migliorare la salute personale e pubblica, che è poi lo scopo ultimo dell’alfabetizzazione alla salute.
Questa sproporzione è confermata dal fatto che non più del 10% degli articoli scientifici pubblicati negli ultimi 25 anni descrive o valuta effettivamente interventi volti a migliorare l’alfabetizzazione alla salute delle persone o delle organizzazioni. Il 90% di tutti i contributi scientifici sull’health literacy sono di natura teorica e descrittiva, esaminano le associazioni tra l’alfabetizzazione alla salute e altre variabili, propongono, testano e convalidano strumenti di misurazione e forniscono un’analisi concettuale dell’health literacy.
In sintesi, l’health literacy suscita l’interesse dei ricercatori, dei professionisti e dei responsabili politici nel campo della salute pubblica da moltissimi anni, ma tale interesse non si è ancora tradotto in progressi sostanziali nello sviluppo di azioni e interventi di salute pubblica (Nutbeam et al. 2018).
Le ragioni di questa situazione non sono difficili da individuare. La valutazione degli interventi è spesso complessa e disordinata. E i risultati sono spesso ambigui e contestati. Inoltre, gli esempi disponibili sono riferiti a contesti ristretti che hanno come destinatari gruppi di popolazione altamente selezionati, rendendo quindi spesso difficile adattare i risultati a livello di popolazione generale.
Nonostante queste sfide, è evidente un bisogno impellente di ulteriori ricerche e sperimentazioni sul campo per sviluppare l’health literacy, ritenuta un fondamentale determinante di salute e un forte alleato per il contrasto delle disuguaglianze. E’ quindi necessario investire in ricerca e studi che migliorino la comprensione non solo di “cosa fare”, ma anche su “come farlo”. Il primo si concentra su approcci specifici per migliorare l’alfabetizzazione sanitaria delle persone; il secondo su come creare un ambiente favorevole che renda l’attuazione più facile ed efficace.
In linea generale, le prove a sostegno dell’attuazione di politiche nazionali sullo sviluppo dell’health literacy e la conseguente creazione di “ambienti favorevoli all’alfabetizzazione sanitaria” e di interventi pratici, non vengono prodotte ancora al ritmo necessario per rispondere alle sfide che si trova e si troverà sempre più ad affrontare la salute pubblica.